“Definire l’Esistenza” intervista a Rocco Bruno
#RoccoBruno
#RobertVonSachsenBellony
#RivoluzioneCognitiva
#RivoluzioneAntropologica
25 dicembre 2025
by Robert Von Sachsen Bellony

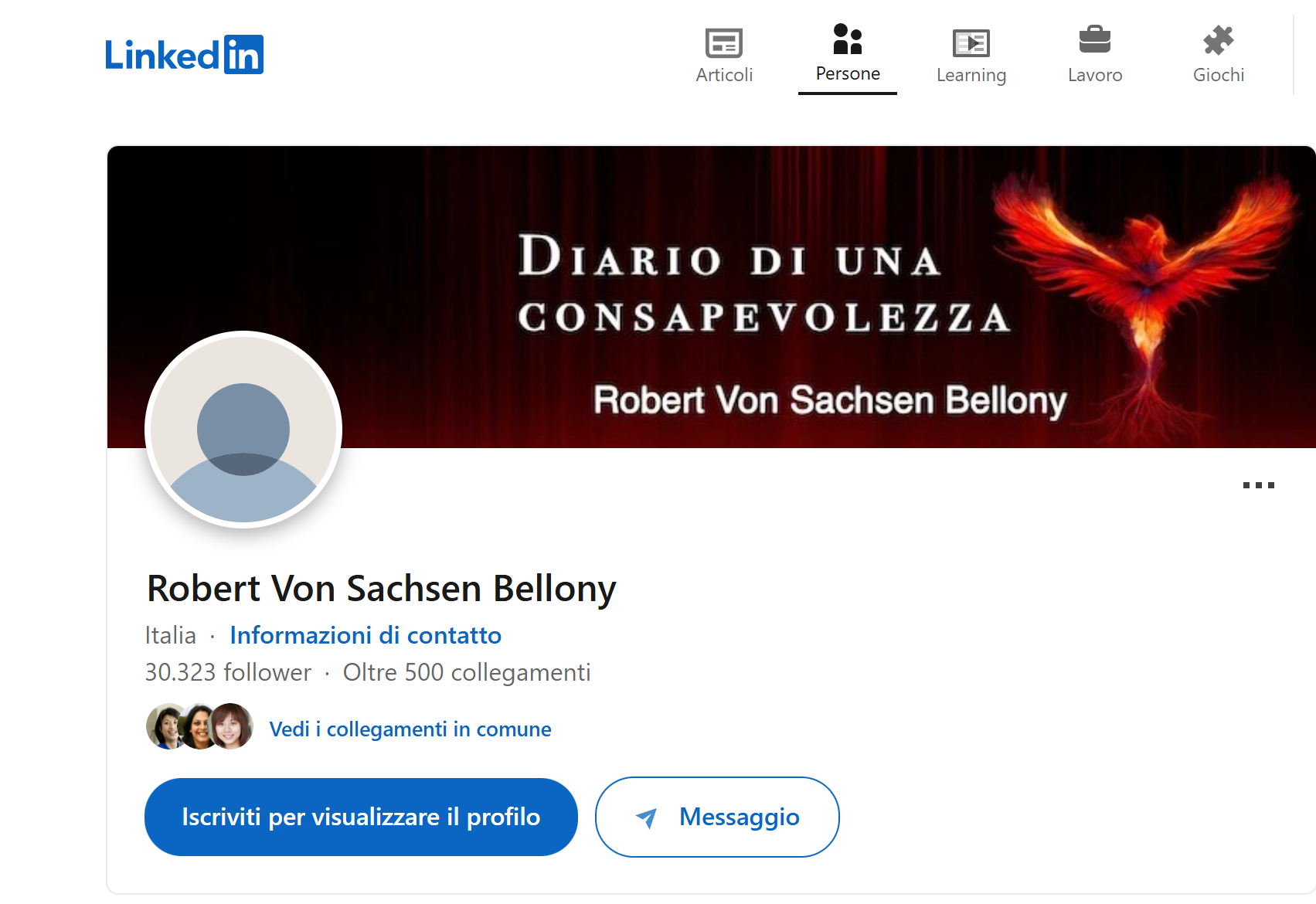
#RoccoBruno

PREMESSA D’OBBLIGO
Ci sono momenti in cui la coscienza appare e scompare. Non perché manchi, ma perché non è ancora in grado di sostenersi. È intermittente. E quando appare, non porta consolazione, ma chiarezza. Una chiarezza che non sempre è facile da reggere nel corpo.
È da qui che nasce tutto il mio lavoro. Non da una dottrina, non da un sistema, ma dall’esperienza diretta di questa intermittenza. Dall’evidenza che l’essere umano può vedere qualcosa di essenziale di sé, e poi perderlo. Non per distrazione, ma perché ciò che vede è più vasto della struttura che dovrebbe contenerlo.
Quando la coscienza emerge, anche solo per brevi istanti, ciò che cade per primo è il livello della conoscenza. Non perché sia falso, ma perché diventa insufficiente. Le spiegazioni, le mappe, persino quelle spirituali, smettono di funzionare. Resta una domanda nuda, prepotente: che cosa sono? E insieme a questa domanda ne sorgono altre, ancora più radicali: perché morire? Cosa muore davvero?
Queste domande non sono teoriche. Si manifestano nel corpo. Il corpo reagisce perché non è abituato a ospitare una coscienza che non si identifica con la biologia né con la psiche. Si avverte espansione, vertigine, talvolta dolore. Non come segno di errore, ma come attrito tra livelli che non sono ancora integrati.
È importante dirlo subito: l’esperienza di coscienza non coincide con la stabilità. Anzi, finché l’essere umano non ha compiuto un lavoro profondo di autoconoscenza e integrazione, la coscienza e l’esperienza di Sé possono solo apparire a intermittenza. Questo spiega perché anche esperienze totalizzanti — quelle che la tradizione attribuisce ai santi o ai mistici — tendono col tempo a perdere intensità. Non perché fossero illusorie, ma perché mancava la struttura interiore per sostenerle.
In assenza di questo lavoro, accade qualcosa di molto preciso: l’esperienza viene appropriata dalla Psiche che crea un nuovo aggregato psichico. Nasce quello che chiamo ego mistico o spirituale, molto più complesso da gestire, perché vive di presunzione. L’individuo non vive più l’esperienza, ma la ricorda, la racconta, la difende. La trasforma in identità. È qui che nasce il mitomane spirituale: non per malafede, ma per mancata integrazione.
Io non ho mai cercato di accumulare esperienze. Al contrario, sono stato costretto a interrogarmi sul perché queste esperienze sorgessero e poi svanissero. E la risposta, col tempo, è diventata chiara: l’Osservatore non può stabilizzarsi finché le parti frammentate dell’io — gli aggregati psichici, le memorie procedurali di minaccia, i vissuti irrisolti — non vengono riconosciute e integrate.
Questo lavoro non è mistico. È sobrio, spesso faticoso, a tratti spietato. Richiede di rimettere in discussione tutto ciò che si crede di essere. Ed è qui che emerge un dolore particolare, che non ha nulla di patologico: un dolore lucido. Non è tristezza, non è paura. È il dolore che nasce quando la coscienza vede senza più potersi sottrarre e capisce la dimensione immensa che è chiamata a colmare. Se questo è essere uno con l’universo, a me sta bene, ma l’uomo, la sua psiche non è pronta a contenerlo. Il Lavoro di scuola diventa fondamentale e non è certo che possa dare risultati definitivi, visto che l’uomo tende a sottrarsi dalla verità che lo riguarda e si pone nelle condizioni di circoscrivere la sua esperienza a ciò che gli è famigliare. Vuoi mettere la rassicurante tranquillità di un “condominio”. Tutto è circoscritto, non devo sentire l’inadeguatezza di vivere un’esistenza senza senso.
Quando questo dolore si manifesta, non paralizza. Al contrario, una forza innata attraversa il corpo e la presenza generale. È una forza che non chiede consolazione e non cerca spiegazioni. Muove. È ciò che rende possibile restare nel mondo senza colludere con la perdita di senso che lo attraversa.
Ed è anche da qui che nasce il mio sguardo sulla tecnologia e sul momento storico che stiamo vivendo. La tecnologia non ha creato il vuoto dell’uomo: lo ha reso visibile. Sta rivelando una mancanza che l’umanità ha sempre avuto, ma che oggi non può più ignorare. Abbiamo sviluppato mezzi enormi senza una maturazione equivalente della coscienza che li utilizza. Questa è quella che chiamo adolescenza tecnologica.
Non credo che la tecnologia sia il problema, né che la salvezza stia in un ritorno romantico al passato. Credo che siamo di fronte a una soglia. Per la prima volta l’essere umano è messo nelle condizioni di non poter più delegare la responsabilità della propria violenza, della propria reattività, della propria inconsapevolezza. Il potere è troppo grande per fingere innocenza.
Questo apre due possibilità: o una regressione distruttiva, alimentata da valori ormai esauriti, o un salto di consapevolezza che permetta all’uomo di evolvere oltre la condizione di animale intellettuale. Non c’è garanzia che accada. Ma l’occasione è reale.
Tutto ciò che dico nasce da qui. Non da una fede, non da un’ideologia, ma dall’impossibilità di mentire su ciò che ho visto e vissuto. Il mio lavoro non propone soluzioni, né promette salvezze. Propone un atto preliminare: guardare con onestà radicale ciò che siamo diventati, e ciò che potremmo ancora diventare.
Sulla Cosmogonia dell’Osservatore
“Nel suo testo si evoca l’Osservatore come nucleo creativo affine al Cristo. Potrebbe disvelare come questa figura trascenda l’ermeneutica gnostica, fondendo ontologia ed epifania magica? Quale rito alchemico interiore presiede alla sua manifestazione?“
Per comprendere cosa intendo con il termine Osservatore, è necessario chiarire prima che cosa nasce, e in quali condizioni nasce. L’essere umano non viene al mondo come coscienza compiuta, ma come essenza vitale che deve fare i conti con un corpo, una psiche e un ambiente che la precedono. Il corpo ha un suo “software di base”, un insieme di funzioni biologiche orientate alla sopravvivenza. La psiche si struttura progressivamente come interfaccia tra l’essenza e il mondo, attraverso l’esperienza.
Il problema non è questo processo in sé, ma il contesto in cui avviene. L’essenza nasce oggi in una civiltà che non conosce sé stessa, che non si interroga sulla propria natura e che ha ridotto l’essere umano a un insieme di funzioni: produttive, sociali, biologiche. In questo contesto, la coscienza non viene coltivata come facoltà primaria, ma subordinata ai bisogni della psiche di base.
Durante lo sviluppo, soprattutto nei momenti di immaturità, l’individuo vive eventi che vengono percepiti come minacce, reali o soggettive. In risposta, la psiche attiva meccanismi di sopravvivenza che lasciano tracce profonde. Si formano così quelli che chiamo aggregati psichici: nuclei di memoria e reazione che restano attivi anche quando la minaccia non esiste più. È da qui che nasce la frammentazione dell’io.
Questa frammentazione, quando la coscienza tenta di emergere, assume una funzione oppositiva che non ha nulla di morale o metafisico, ma che riguarda la difesa automatica dell’equilibrio psichico. Tornerò su questo punto più avanti.
È importante chiarire che ciò che chiamo aggregati psichici non coincide con il ricordo narrativo degli eventi vissuti. Il vissuto irrisolto non si conserva principalmente sotto forma di memoria cosciente o di racconto interiore, ma come traccia procedurale. Si inscrive nel corpo, nei pattern di attivazione neurochimica, nelle posture, nelle tensioni, nelle sensazioni viscerali e nei riflessi automatici.
Questi schemi si riattivano senza che l’individuo debba pensarci. Non passano dal linguaggio, né dalla volontà. Si manifestano come stati improvvisi, reazioni emotive sproporzionate, impulsi comportamentali che sembrano “precedere” la coscienza. È per questo che il solo comprendere razionalmente un vissuto non è sufficiente a scioglierlo. La narrazione arriva sempre dopo.
Il lavoro di autoconoscenza non consiste quindi nel ricordare meglio, ma nel riconoscere questi pattern mentre si attivano, nel corpo e nella psiche, attraverso la presenza. Solo così ciò che è procedurale può essere portato gradualmente alla coscienza e integrato, permettendo all’energia che lo alimentava di liberarsi.
È in questo scenario che utilizzo il termine Cristo. Non come figura religiosa, né come oggetto di fede, ma come archetipo funzionale. Il Cristo rappresenta la qualità e la volontà presenti in ogni essere umano di riunificare ciò che è stato frammentato. È l’impulso al perfezionamento di sé, non in senso morale, ma evolutivo. È ciò che sorge quando l’individuo comincia a sentire che ciò che gli è stato insegnato non esaurisce ciò che è.
L’Osservatore nasce esattamente qui. Non è un automatismo, né una funzione che emerge per caso. All’inizio può apparire come una frattura spontanea nel processo di adattamento: il sorgere di domande che non trovano risposta nel sistema di riferimento dominante. Successivamente, diventa una funzione coltivabile attraverso la presenza.
La presenza, però, non è fine a se stessa. Serve a raccogliere dati, a vedere come l’io reagisce, come si difende, come si frammenta. Serve soprattutto a mettere in crisi l’immagine che l’individuo ha di sé. Solo dopo questa presa di coscienza diventa possibile un lavoro reale di autoconoscenza.
Il cosiddetto rito alchemico interiore non consiste in pratiche simboliche, ma nella trasformazione della materia umana. La personalità, essendo in gran parte un prodotto culturale, è modificabile. Ma la vera trasformazione avviene quando i frammenti psichici vengono integrati e l’energia che li alimentava viene restituita all’essenza. È in questo senso che l’ego non va distrutto, ma trasceso per inclusione.
Quando questo processo inizia, l’Osservatore smette gradualmente di essere intermittente. Non perché l’individuo “si illumini”, ma perché la frammentazione perde potere. La coscienza trova spazio nel corpo e nella vita quotidiana. E il Cristo, inteso come forza di riunificazione, smette di essere un simbolo e diventa un principio operativo.
Un aspetto decisivo di questi pattern procedurali è che la risposta che generano è sempre anacronistica. La reattività non è mai aggiornata a ciò che sta realmente accadendo nel presente. È la ripetizione automatica di una risposta che aveva senso in un altro tempo, in un altro contesto, spesso in una fase di immaturità dell’essere. Il corpo e la psiche reagiscono come se la minaccia fosse ancora attuale, anche quando non lo è più.
Questo chiarisce in modo preciso cosa intendo quando parlo di coscienza addormentata. Non si tratta di un sonno fisico né di una mancanza di intelligenza. È uno stato di autoipnosi funzionale, in cui l’individuo vive e agisce senza mediazione. Tra lo stimolo e la risposta non c’è un osservatore, non c’è uno spazio di coscienza che possa verificare se ciò che accade ora corrisponde davvero a ciò che viene percepito.
In questa condizione, l’essere umano non è presente a se stesso, ma agito da automatismi. Non sceglie, reagisce. Non vede, ripete. È per questo che la coscienza, quando emerge, viene vissuta inizialmente come qualcosa di innaturale o destabilizzante: introduce una discontinuità in un sistema che funzionava, seppur in modo riduttivo.
Il risveglio non consiste quindi nell’aggiungere qualcosa di nuovo, ma nel reinserire la mediazione. L’Osservatore è precisamente questo: la funzione che interrompe l’autoipnosi, aggiorna l’esperienza al presente e rende possibile una risposta adeguata a ciò che è, non a ciò che è stato.
Sulla Dialettica Ego/Coscienza
“L’Ego viene descritto come ‘Satana interiore’, una cristallizzazione karmica. Come si articolerebbe, secondo la sua ricerca, il processo di solve et coagula necessario a trasmutare queste scorie psichiche in luce cosciente?”
Quando utilizzo espressioni come “Satana interiore” o “principio diabolico”, non mi riferisco a figure morali o religiose, ma a funzioni precise dell’esperienza umana. È utile, a questo punto, distinguere i due livelli.
Il termine diabolico, dal greco diábolos, rimanda al principio della separazione, della frammentazione. È ciò che divide l’unità originaria dell’esperienza in una molteplicità di io-causa, ciascuno generato da un vissuto irrisolto. Ogni evento che l’essenza non è stata in grado di integrare produce una scissione: nasce un frammento psichico che rimane attivo nel tempo e che, al presentarsi di stimoli analoghi, sequestra il corpo e la reazione.
In questo senso l’ego non è uno, ma molti. Una costellazione di io che agiscono in modo anacronistico, come se il passato fosse ancora presente. Questa frammentazione è il vero stato di prigionia dell’uomo, perché impedisce una presenza unitaria e lo condanna a una reattività automatica.
Il termine Satana, invece, nel suo significato originario di avversario o oppositore, descrive la funzione che questi frammenti assumono quando la coscienza tenta di emergere. Ogni movimento verso una maggiore lucidità incontra una forza oppositiva, non perché vi sia un male intenzionale, ma perché quelle strutture esistono per mantenere un equilibrio di sopravvivenza. Il Satana interiore è dunque ciò che si oppone al cambiamento, ciò che resiste alla perdita di controllo.
È solo in presenza della qualità della coscienza che l’individuo può fare esperienza di ciò che comunemente viene chiamato rimorso o pentimento. Non in senso morale, ma come presa d’atto immediata che la reazione avuta non è allineata a parametri più profondi dell’essere umano. Non parametri animali o viscerali, ma elettivi, legati alla possibilità di scegliere e non solo di reagire.
Non è casuale che nelle tradizioni esoteriche queste funzioni vengano spesso rappresentate in forma animale. Non come condanna dell’istinto, ma come riconoscimento del fatto che l’uomo condivide con le altre forme di vita impulsi primordiali. Il problema nasce quando questi impulsi, in assenza di coscienza, assumono il comando esclusivo del comportamento.
In questo quadro, il karma va inteso nel suo significato più essenziale: causalità. Non una legge giuridica o morale, ma un principio ovvio in un universo causale. Se la bilancia interna pende verso un vissuto irrisolto, l’effetto sarà una reattività priva della partecipazione cosciente dell’individuo. Nessuna colpa, solo meccanica.
Il solve et coagula alchemico descrive il lavoro di trasformazione di queste strutture. Il solve avviene quando la coscienza riconosce la frammentazione senza identificarvisi. Il coagula avviene quando l’energia prima imprigionata nei frammenti viene reintegrata in una presenza più ampia e unificata.
In questo senso, il principio satanico non è un nemico da sconfiggere, ma una soglia. E il principio diabolico non è un errore, ma una conseguenza. Attraversarli consapevolmente è ciò che permette alla luce cosciente di emergere non come ideale, ma come esperienza viva.
Il termine ego non deve essere inteso come un’entità unitaria né un difetto morale. L’ego, per come lo intendo, è l’effetto emergente della frammentazione in molto “io” psicologici. È l’insieme dei pattern procedurali che si alternano nel governo del comportamento quando manca una funzione di mediazione cosciente, funzione assente a causa del modo “atipico” con cui veniamo istruiti sin dai primi anni d’infanzia. Non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che accade quando l’Osservatore non è presente.
Capiamo così che Satana e il Diavolo sono figure retoriche costruite per insegnarci qualcosa che ci riguarda da vicino, l’umano moderno ignora cose che lo riguardano profondamente da vicino: la dispersione dell’essenza in molteplici pattern procedurali reattivi, ciascuno attivato da un vissuto che per mancanza di gnosi risulterà irrisolto. Ogni “diavolo” è un automatismo che si attiva in risposta a una minaccia percepita, reale o apparente. In questa fase, l’io è diviso, incoerente, oscillante. Il diavolo non è quindi un’entità, ma la dinamica stessa della disgregazione interiore e da distinguere in termini antropologici e simbolici da Satana.
Il termine Satana, dall’ebraico satan, indica l’avversario o l’oppositore, un’opposizione che non va intesa come volontaria o intenzionale. Ciò che si oppone non sceglie di farlo. È il pattern procedurale dell’io che, non essendo mediato dalla coscienza, reagisce automaticamente alla minaccia percepita della perdita di controllo. L’opposizione è quindi apparente. Non nasce da una volontà autonoma, ma dall’attivazione strutturale della biologia della sopravvivenza. Poiché questi pattern non si avvalgono di memoria narrativa né di riflessione, ma operano a livello procedurale, la reazione si manifesta come resistenza al cambiamento, irrigidimento, difesa. Non c’è un “nemico interiore”, ma un sistema che non ha ancora accesso alla scelta.
Satana è l’aggregazione o cristallizzazione, come opera karmica, ovvero, come causa ed effetto, della presenza di memorie, pattern e programmi di biologia sensata, che non restano isolati, ma si aggregano intorno ad un’unica idea di sé stessi. Quando più automatismi convergono attorno a un’unica idea di minaccia dominante, si crea un centro di gravità psichico. È questo centro che può essere chiamato Satana: un alter ego potente, strutturato, coerente nella sua opposizione, quello che in altri termini verrebbe chiamato un Hassnamuss: entità con un doppio centro di gravità. Ecco che sorge nella comprensione generale del discorso la ragione della relazione culturale forte tra Diavolo/i e Satana quale capo indiscusso.
L’opposizione non è scelta né volontà malvagia, è l’effetto di un aggregarsi della psiche intorno a un falso Sé. È una strategia di sopravvivenza estrema. La biologia, percependo una minaccia globale all’identità o alla continuità, organizza i propri automatismi in un’unica configurazione difensiva. Più la minaccia viene restimolata, più questa configurazione si rafforza.
Satana non è quindi un’entità autonoma, ma un effetto emergente. Non esiste prima dell’uomo, né al di fuori dell’uomo. È il risultato di una coscienza assente che lascia la gestione dell’esistenza a un sistema biologico costretto a difendersi senza comprensione, e questo accade per mancanza di formazione nei primi anni d’infanzia. La Coscienza, Pistis Sofia (Fede e Volontà) non è assente viene riorientata e confusa, in gnosi si direbbe: ingannata. Per questo l’ego può agire perché si avvale del potenziale della Coscienza stessa. Va detto a questo punto che l’ego di per sé non esiste, è solo un modo in cui prende forma la nostra Essenza. L’attuale Civiltà che non conosce questi meccanismi, cioè sé stessa, crea l’apparato formatorio, la Forma con cui funzioneremo per il resto della vita.
In questo senso, Satana è reale come funzione, ma non come essere. È crudele non per cattiveria, ma perché non conosce altro linguaggio se non quello della sopravvivenza. Quando la coscienza introduce mediazione, questo centro di gravità perde coesione. I pattern si disaggregano. L’alter ego si svuota. Non viene sconfitto: si dissolve per mancanza di necessità.
Satana è una figura retorica lasciata dai nostri antenati che conoscevano e hanno capito le conseguenze di liberare tale Bestialità in un uomo incompleto. Non nasce per indicare un’entità esterna da combattere, ma per dare forma simbolica a un processo interno reale: l’aggregazione dei pattern difensivi attorno a una minaccia percepita come assoluta, una minaccia che, nel corso del tempo, è stata progressivamente abbassata ai bisogni primari. Quando l’orientamento ancestrale dell’essere umano perde significato, trascendenza e coscienza si perdono, la sopravvivenza biologica diventa l’unico criterio di riferimento.
La retorica di Satana rende visibile ciò che, altrimenti, resterebbe indistinto e agito inconsapevolmente.
Il rischio, tuttavia, emerge quando questa figura, Satana, viene intesa come un nemico reale da sconfiggere, l’attenzione si sposta dall’osservazione del funzionamento interno alla lotta contro un presunto avversario esterno. Satana diventa la minaccia e in questo modo, l’opposizione si rafforza anziché dissolversi. La fissazione sulla necessità di combattere Satana finisce per riprodurre esattamente la dinamica che Satana rappresenta: un centro di gravità rigido, oppositivo, totalizzante.
Paradossalmente, è proprio il bisogno di sconfiggere Satana che può diventare satana. Non perché vi sia malafede, ma perché l’energia della coscienza viene catturata dalla logica della lotta, anziché essere impiegata nella comprensione. La tradizione del pensiero esoterico, letta in chiave simbolica e funzionale, non riguarda l’espulsione di un’entità, ma il venir meno di una configurazione difensiva che non ha più ragione di esistere: quando la coscienza è mediatrice, non c’è nulla da scacciare. C’è solo qualcosa che smette di essere necessario. In questo senso, il vero “esorcismo” non è un atto di forza, ma un atto di lucidità.
È in questo slittamento che una parte di responsabilità ricade inevitabilmente sulla civiltà. Una civiltà che ignora la natura dell’essere umano, che non educa alla conoscenza di sé e che riduce l’esistenza a produzione, competizione e sicurezza, finisce per rafforzare proprio quelle configurazioni difensive che poi attribuisce al “male”. In assenza di una bussola interiore, la minaccia viene percepita ovunque e la reazione diventa permanente.
La figura di Satana rende visibile questo stato di cose: non come causa, ma come effetto collettivo di una coscienza abbassata e non mediata. L’alter ego oppositivo (Satana interiore) si rafforza nella misura in cui l’essere umano viene mantenuto in una condizione di allerta continua, separato dalla propria natura più profonda e costretto a difendere ciò che crede di essere. L’ulteriore degenerazione di questa dinamica, forse la più pericolosa, si manifesta quando l’alter ego oppositivo (Satana interiore) non solo si consolida, ma si riveste di verità assoluta. In questo caso, la configurazione oppositiva non si percepisce più come reazione, ma come giustizia. Il sentirsi “dalla parte del giusto” diventa il lasciapassare per ogni forma di violenza.
Quando una mente frammentata si convince di incarnare il bene, la distruzione smette di essere vissuta come tale e viene razionalizzata come necessaria. È in questo passaggio che l’ipocrisia raggiunge il suo apice: si proclama la verità mentre si agisce la negazione della coscienza. Non si vede più l’altro come essere umano, ma come ostacolo, errore, male da estirpare.
Storicamente, ogni forma di carneficina, genocidio o distruzione sistematica è stata preceduta da questo stesso schema: una verità dichiarata assoluta, una minaccia percepita come totale, e una coscienza ridotta ai bisogni primari della sopravvivenza del gruppo. La violenza non nasce dall’assenza di valori, ma dalla loro assolutizzazione in assenza di coscienza.
In questo senso, chi si erge a portatore della verità assoluta senza conoscenza di sé non si oppone a Satana: lo incarna. Non perché sia malvagio, ma perché agisce da una posizione non mediata, incapace di riconoscere la propria reattività. La convinzione di essere nel giusto diventa il centro di gravità che giustifica tutto. Un’altra forma raffinata di quella stessa dinamica che sto descrivendo la troviamo nel modo con cui implicitamente viene spesso usato oggi il termine inclusivo. Non indica integrazione reale, ma assimilazione forzata sotto una verità che si proclama superiore.
La coscienza, al contrario, non può essere assoluta né totalizzante. Non assimila l’altro a una verità predefinita, né lo “include” ridefinendone l’esperienza dell’altro, dall’alto. Dove c’è coscienza, c’è riconoscimento della differenza e limite del proprio punto di vista. Ogni verità che ha bisogno di inglobare l’altro per affermarsi segnala non apertura, ma dominio. La coscienza non integra imponendo, ma riconosce senza appropriarsi. Non ha bisogno di includere l’altro in una verità assoluta, perché non teme il confronto con ciò che non coincide con sé.
In questo senso, parlare di “trascendere l’ego” è spesso fuorviante. L’ego non si trascende con un atto di volontà, né con un’idea più elevata di sé. Si riduce di potere solo quando le sue componenti vengono viste e integrate. Finché questo non accade, l’individuo è letteralmente agito da stati che si succedono, ciascuno convinto di essere il centro.
È qui che il concetto di karma o di cristallizzazione karmica va riportato alla sua semplicità originaria. Il karma non è una legge morale né una punizione differita. È causalità. È il naturale concatenarsi di cause ed effetti in un sistema che non è aggiornato al presente. Se uno stato procedurale di minaccia si attiva, l’effetto sarà una risposta di difesa, anche quando non ce n’è motivo. La catena causale non chiede consenso: si attiva automaticamente. Il processo di solve et coagula necessario a trasmutare queste scorie psichiche in luce cosciente consiste nell’essere coscienti di questi stati.
L’essere umano tende a credere che siano le circostanze a determinare il suo stato interiore, ma accade esattamente il contrario. Gli stati interiori, attraverso il corpo, determinano le circostanze. La postura, il tono della voce, lo sguardo, la tensione muscolare, il ritmo dei gesti: tutto comunica uno stato prima ancora che intervenga il linguaggio. Gli altri rispondono a questa configurazione in modo pre-razionale, attivando a loro volta stati analoghi o complementari.
È così che si creano relazioni conflittuali, dinamiche di potere, competizioni e incomprensioni che sembrano “capitare”, ma che in realtà sono co-create. Non per colpa, ma per inconsapevolezza. In assenza di mediazione, il mondo diventa uno specchio che riflette continuamente stati non visti.
In questo contesto si inserisce il tema della sincronicità. Le sincronicità non sono eventi magici né prove di elezione spirituale. Sono indicatori. Segnalano che qualcosa nella configurazione interna sta cambiando. Quando l’Osservatore inizia a essere attivo, anche se in modo intermittente, introduce una discontinuità nella catena automatica causa-effetto. Lo stato non viene più immediatamente convertito in comportamento.
Questo spazio, anche minimo, modifica il campo relazionale. Le cosiddette “coincidenze significative” emergono perché l’individuo non sta più proiettando in modo massivo i propri pattern sul mondo. Non è che gli eventi obbediscano alla volontà, ma cessano di essere piegati da una reattività costante. Il reale comincia a mostrarsi per quello che è, non solo per quello che conferma.
È importante sottolineare che questo non equivale a controllo. Anzi. Più l’Osservatore è presente, meno c’è bisogno di controllare. L’attenzione si sposta dal tentativo di gestire gli eventi alla comprensione degli stati che li precedono. È qui che il lavoro interiore mostra la sua efficacia concreta: non promette risultati, ma riduce l’attrito tra l’essere umano e ciò che accade.
Con il tempo, e solo con il tempo, questo processo produce un cambiamento reale nella qualità della presenza. La reattività perde intensità, non perché venga repressa, ma perché viene riconosciuta come anacronistica. Il comportamento si fa più essenziale, meno difensivo. L’individuo non diventa “migliore”, ma più adeguato al presente. In questo senso, la coscienza non è uno stato elevato da raggiungere, ma una funzione di aggiornamento continuo. Quando è assente, l’essere umano vive in un passato che si ripete. Quando è presente, anche solo a tratti, il presente diventa finalmente accessibile. E questo, da solo, modifica il rapporto con il mondo più di qualsiasi tentativo di cambiamento esterno.
Sulla Sincronicità e Legge degli Accidenti
“Gli eventi sincronici vengono posti in relazione con l’egregore individuale. Potrebbe elaborare come l’adepto, attraverso la disciplina dell’attenzione, possa divenire architetto di quelle ‘coincidenze significanti’ che sfidano il velo di Maya?”
Quando si parla di sincronicità, il rischio è sempre quello di scivolare in una lettura magica o superstiziosa degli eventi. Nel mio lavoro, invece, la sincronicità non è qualcosa che accade all’individuo, ma qualcosa che diventa percepibile quando cambia la qualità della sua presenza.
Finché l’uomo è frammentato nei suoi io-causa, l’attenzione è dispersa e reattiva. La realtà viene vissuta come una sequenza di accidenti, eventi casuali privi di legame apparente. In questa condizione, ciò che chiamiamo egregore individuale non è altro che il campo di risonanza prodotto da una psiche disorganica, governata da bisogni di sopravvivenza e da vissuti irrisolti.
Quando però l’Osservatore entra in funzione e l’essenza comincia a rioccupare il corpo e la psiche, l’attenzione si ricompone. Non diventa più intensa nel senso dello sforzo, ma più pulita. È questa disciplina dell’attenzione — che non è concentrazione forzata, ma presenza non reattiva — a modificare il modo in cui l’individuo entra in relazione con il mondo.
In questo stato, gli eventi non vengono più intercettati casualmente, ma per risonanza. Le cosiddette “coincidenze significative” non sono violazioni delle leggi naturali, ma il risultato di un allineamento interno. L’essenza, non più frammentata, emette un campo coerente, e ciò che prima appariva come caos comincia a mostrare una trama. Va anche notato, per non cadere in semplificazioni, che l’Osservatore non entra in funzione in modo automatico, né la coscienza si sviluppa per caso. Non esiste un risveglio involontario, così come la volontà che ho definito Cristo non è il prodotto di un processo inconscio. Senza questo chiarimento si rischia di trasformare l’Osservatore in un’astrazione o, peggio, in un effetto collaterale del caos.
L’Osservatore comincia a farsi presente attraverso un atto preciso: la stimolazione della presenza, a prescindere da ciò che si pensa, si crede o si sta facendo. È un gesto interiore intenzionale, non uno stato emotivo. In questo senso, il concetto di Ricordo di sé, così come formulato da Gurdjieff, è centrale e pienamente operativo. Domande semplici e radicali come Chi sono? Cosa sto facendo? Dove sono? interrompono per un istante la reattività automatica e riportano l’essenza nel presente.
In quel momento avviene qualcosa di molto concreto: l’energia che si era fissata in una reazione emotiva viene redistribuita. Il “codice” che si era irrigidito si allenta, e la coscienza recupera margine di manovra. Questo è il primo atto reale dell’Osservatore. Non un’interpretazione, ma una presenza che vede. Purtroppo la mente non è addestrata a restare nel presente, e nuovi schemi comportamentali affioreranno per indurci a cambiare punto di percezione. L’uomo risvegliato non è sveglio, è risvegliato, i suoi stati di sveglia sono transitori, e accadono solo quando se lo ricorda, È questa la natura del ricordo di sé.
Sono gli stati interiori a determinare le circostanze, e non il contrario, è questa la vera natura della “sincronicità” o della legge dell’”accidente”. Lo stato d’animo di un individuo, che egli ne sia cosciente o meno, modifica la morfogenesi del corpo: postura, espressioni facciali, tono della voce, comportamento. Questa configurazione viene immediatamente percepita dagli altri a un livello pre-razionale, emotivo, e attiva risposte che non passano dalla mediazione mentale. È così che si crea una catena di eventi coerente con lo stato di partenza. Esserne coscienti trasforma la legge dell’accidente in sincronicità, comincio a capire il “perché” dei miei accadimenti e provo ad introdurre nuove modalità di presenza e affino l’auto-osservazione.
Le sincronicità non sono quindi forzature del destino né violazioni delle leggi naturali. Sono il risultato di un allineamento interno. Quando l’uomo non è più governato dalla reattività, il velo di Maya non viene squarciato, ma diventa trasparente. E ciò che prima appariva come caso comincia a rivelare una trama. In questo senso l’adepto non è un mago che manipola le coincidenze, ma un uomo che ha imparato a stare presente. E la sincronicità, lungi dall’essere un obiettivo, diventa una conseguenza naturale del ritorno all’unità. Dire che l’adepto diventa “architetto” delle sincronicità non significa attribuirgli un potere di controllo sugli eventi, ma riconoscere che, quando l’opposizione interna si riduce, l’interazione con il reale cambia. Il velo di Maya non viene squarciato con un atto di volontà, ma diventa trasparente nel momento in cui l’individuo smette di proiettare su di esso le proprie divisioni interne.
La sincronicità, allora, non è un fine, né una prova spirituale. È un effetto collaterale del ritorno all’unità. Quando l’uomo smette di essere diviso, anche il mondo smette di apparirgli come frammentato. Questa ovviamente è una sintesi, dato che per stabilirsi saldamente in un tale stato intimo, l’uomo è chiamato a ripetute azioni mirate all’integrazione dei suoi stati verso l’integrità; è questa la natura dell’Opera Alchemica. L’essere protesi al Presente è strumento non fine, ed è tale e necessario a causa del fatto che la reattività della psiche umana è sempre anacronistica. La risposta automatica non appartiene al presente, ma a un tempo passato che continua ad agire come se fosse ancora attuale. La presenza, tuttavia, non va confusa con una soluzione immediata. Osservare sé stessi non significa essere già allineati, ma iniziare a raccogliere dati sulla propria frammentazione. I momenti di lucidità, i bagliori di coscienza, non sono uno stato permanente, né potrebbero esserlo finché la reattività rimane attiva. Sono aperture temporanee che hanno senso solo se vengono utilizzate come materiale di comprensione.
È attraverso un lavoro di retrospezione e di ricapitolazione che questi momenti diventano realmente trasformativi. Vedere una reazione non basta: occorre comprenderne l’origine, riconoscere gli accadimenti che hanno fissato determinate risposte automatiche e riportarli alla coscienza. Le memorie procedurali di minaccia, soprattutto in ambito relazionale, possono essere elaborate solo se l’individuo ha iniziato a osservare ciò che accade nella propria psiche e nel corpo, invece di identificarsi con esso.
Solo quando questo lavoro produce un reale scioglimento delle cause, e non soltanto una momentanea sospensione degli effetti, il rapporto con gli eventi esterni comincia a cambiare. In questo senso, la sincronicità non è un premio né un traguardo, ma un indicatore. Segnala che qualcosa, all’interno, sta iniziando a ricomporsi. Il velo di Maya non viene strappato, ma diventa gradualmente più limpido, nella misura in cui l’uomo smette di proiettare su di esso la propria frammentazione.
Il lavoro di coscienza consiste quindi, prima di tutto, nel disaccoppiare il tempo, retrospezione e ricapitolazione hanno questa utilità: permettere all’organismo di riconoscere che ciò che sta accadendo ora non coincide più con il contesto in cui la memoria è stata registrata. L’essere umano è chiamato ad aggiornare sé stesso e diventare sincrono, ovvero allineato a ciò che realmente sta accadendo.
È importante comprendere che la memoria che governa la reattività non è narrativa. Non è il ricordo cosciente dell’evento, ma un insieme di dati sensoriali, neurochimici e posturali che si riattivano come configurazione globale. La memoria si scioglie solo quando il corpo–psiche sperimenta una possibilità reale di scelta e riconosce che il tempo è diverso, pur in presenza di stimoli che somigliano a quelli originari.
Qui si comprende anche il funzionamento profondo della psiche: essa non cerca il benessere, ma la familiarità biologica. Il sistema psico-bio-neuro-vegetativo tende verso ciò che è conosciuto e prevedibile, anche quando è doloroso. Non perché vi sia un desiderio inconscio di soffrire, ma perché ciò che è noto offre un’illusione di controllo: “Se devo spiegarmi fino a svuotarmi, non sto cercando comprensione: sto cercando il permesso di esistere.”, nessun essere umano dovrebbe negoziare il diritto di esistere.
In questo senso, molte semplificazioni legate alla cosiddetta legge dell’attrazione o a una lettura ingenua della sincronicità risultano fuorvianti. Non attraiamo persone o situazioni in base a un desiderio astratto. Il nostro sistema riconosce configurazioni note e vi si orienta automaticamente. Ciò che ritorna non lo fa perché “deve essere rivissuto”, ma perché non è ancora stato messo al sicuro. Una memoria non chiede ripetizione: chiede protezione, chiede di non essere più necessaria.
Per questo è un errore pensare che un vissuto si superi rientrando continuamente nella scena che lo ha generato. Si supera uscendone, nel momento in cui il corpo lo chiede. La responsabilità dell’individuo non è capire perché una certa circostanza sia arrivata nella propria vita, né attribuirle un significato espiatorio o karmico in senso morale. La responsabilità è riconoscere quando una situazione produce collasso e non restarvi. Non tutto ciò che entra nella vita deve restarci. La coscienza non può essere chiamata a giustificare ogni evento, ma a discernere ciò che può essere attraversato da ciò che deve essere lasciato. Questo discernimento non nasce da un’idea, ma dall’ascolto profondo del corpo, che è il primo luogo in cui il presente può essere riconosciuto come tale.
Il lavoro di integrazione non combatte i nostri stati alteranti, li rende superflui. Quando l’io non è più frammentato e la coscienza aggiorna il presente, ciò che appariva come avverso si dissolve come funzione non più necessaria. La biologia della sopravvivenza resiste al nuovo. Ogni novità viene percepita come potenziale perdita del conosciuto, o più precisamente della familiarità biologica che rappresenta. Dal punto di vista della sopravvivenza, perdere ciò che è noto equivale a esporsi a una minaccia, reale o apparente. Per questo motivo, quando la coscienza tenta di emergere, il sistema reagisce. Non perché vi sia una scelta di opporsi, ma perché il corpo–psiche attiva automaticamente stati di allerta. Questa attivazione si manifesta come emozione, come stimolazione di specifiche aree cerebrali e come modificazione dei tessuti corporei interdipendenti. L’organismo entra in uno stato di vigilanza difensiva.
Se questa attivazione non viene mediata, viene registrata come memoria procedurale. Ogni successiva esperienza che richiami anche solo parzialmente quella configurazione sensoriale riattiva l’allerta. In questo modo, l’opposizione diventa strutturale: un alert costante che mantiene l’individuo in uno stato di reazione cronica. Una funzione che avrebbe senso in termini di sopravvivenza diventa disfunzionale quando l’essere umano è chiamato a evolvere oltre l’adattamento automatico. Quando la coscienza si stabilizza e introduce mediazione, l’opposizione perde ragione di esistere. Non viene vinta: cessa di essere necessaria.
Il permanere in scenari che riattivano la memoria non la riduce: la rafforza. Ogni restimolazione, se non mediata dalla coscienza, consolida ulteriormente il pattern procedurale, fino a creare una tendenza alla conservazione di un apparente sicurezza o controllo su di sé. Attribuisce la sofferenza a fattori esterni, a eventi, a persone, a forze oscure, senza vedere che ciò che mantiene il dolore è la ripetizione di uno stato interno non riconosciuto. È fondamentale chiarire che le memorie, i vissuti e i cosiddetti traumi non si riattivano per il contenuto della scena, ma per lo stato del sistema nervoso in cui quella scena è avvenuta. È la configurazione neuro-vegetativa, emotiva e corporea a essere richiamata, non la storia. Per questo motivo, cambiare la narrazione non basta. La psiche non ascolta i racconti: risponde agli stati.
La psiche, infatti, cerca prima di tutto rassicurazione. Questo spiega il grande successo di molte terapie e di molte correnti ideologiche new age. Esse creano ambienti simbolici o relazionali in cui la psiche può sentirsi temporaneamente al sicuro, non minacciata. Ma l’effetto terapeutico dura quanto dura l’assenza di restimolazione. Alla prima attivazione significativa, il sistema ritorna esattamente dove era.
Il problema non è la mancanza di spiegazioni, ma la mancata comprensione di ciò che siamo e di come funzioniamo. Riempire la mente di narrazioni rassicuranti non ha alcun potere sulla reattività della psiche quando viene attivata da un’emozione. Anzi, spesso rafforza l’illusione di aver risolto qualcosa, rendendo la successiva ricaduta ancora più incomprensibile e dolorosa.
La trasformazione reale non avviene cambiando la storia che raccontiamo a noi stessi, ma modificando lo stato da cui quella storia nasce. Questo è possibile solo attraverso la mediazione della coscienza, agita nella retrospezione dei fatti, che non consola né rassicura, ma rende visibile ciò che accade nel corpo e nella psiche, permettendo al sistema di riconoscere che il tempo è cambiato e che la minaccia non è più attuale, in una parola: RICAPITOLAZIONE.
Sull’Esegesi Esoterica dei Sette Peccati
“I vizi capitali sono reinterpretati come sbarre della prigione interiore. Quale corrispondenza ermetica legherebbe ciascun peccato alla corruzione di specifici vortici energetici (chakra) nell’antropologia occulta?”
Quando si osserva l’essere umano dal punto di vista del funzionamento reale, diventa evidente che ciò che chiamiamo comportamento non nasce da una scelta consapevole, ma da una catena ben precisa: il vissuto irrisolto genera stati emozionali, e questi stati, se non mediati dalla coscienza, si traducono automaticamente in comportamento. I comportamenti sono quindi esiti funzionali, non decisioni libere. Sono risposte biologicamente sensate in termini di sopravvivenza, ma spesso profondamente disallineate rispetto al bisogno di integrità dell’essere.
L’emozione non è uno stato soggettivo vago né un contenuto sentimentale. È la modalità attraverso cui la psiche agisce il corpo. L’emozione è un segnale elettro-psichico attivante, che stimola specifiche aree cerebrali e, attraverso di esse, produce una modificazione morfica dei tessuti corporei interdipendenti: tono muscolare, postura, respiro, visceri, sistema neurovegetativo.
In questo senso, l’emozione è il linguaggio operativo della psiche sul corpo. Non descrive ciò che accade: lo produce. Ogni stato emozionale è già un’azione in potenza, una disposizione del corpo all’azione. Quando l’emozione non è mediata dalla coscienza, il corpo viene mosso automaticamente secondo schemi già inscritti, rendendo il comportamento una conseguenza inevitabile.
Questo chiarisce perché il lavoro non possa limitarsi alla comprensione mentale. Finché l’emozione agisce come comando e non come segnale riconosciuto, la macchina umana continuerà a rispondere secondo automatismi anacronistici. La coscienza interviene solo quando l’emozione viene vista per ciò che è: un impulso attivante, non un’identità.
I cosiddetti vizi capitali, letti in questa prospettiva, perdono ogni connotazione morale. Non sono peccati da espiare, ma modalità attraverso cui l’energia psichica, non mediata dalla coscienza, cerca compensazione o difesa. Ognuno di essi nasce da una specifica combinazione di vissuto, emozione e identificazione.
Quando, ad esempio, un’emozione di ingiustizia subita si mescola a un’identità rigida non messa in discussione, l’organismo può strutturare stati di rancore e risentimento. Questi stati, nel tempo, si consolidano in comportamenti ossessivi, aggressivi o compulsivi. Non perché l’individuo sia “cattivo”, ma perché il sistema cerca di ristabilire un senso di controllo e di valore minacciato.
Lo stesso vale per l’invidia, l’avidità, la superbia o l’accidia: ciascuna rappresenta una strategia di adattamento che ha perso il contatto con il presente. La psiche, guidata dalla familiarità biologica, ripete ciò che conosce. E ciò che conosce è ciò che l’ha fatta sopravvivere in un altro tempo. Il problema è che l’essere umano non è solo un organismo che deve sopravvivere: è anche un essere che cerca pienezza, coerenza e senso.
È qui che si struttura la vera prigione interiore. Non una prigione fatta di regole esterne, ma di automatismi interiori che impediscono all’individuo di interrogarsi sulla propria reale natura e origine. L’uomo resta intrappolato in ruoli, identità e comportamenti che scambia per sé stesso. Vive in una ripetizione continua, credendo di muoversi liberamente.
Questa condizione è particolarmente evidente nella dimensione sociale. L’essere umano moderno è stato organizzato in strutture di branco sofisticate, che chiamiamo società. Ma l’uomo non è un animale sociale nel senso biologico del termine. È stato costretto a identificarsi con ruoli funzionali alla sopravvivenza del sistema, abbassando progressivamente le proprie qualità esseriche. In questo contesto, molti comportamenti ritenuti “normali” sono in realtà adattamenti forzati. Man mano che la civiltà si è evoluta tecnologicamente è venuta sempre meno la necessità di attivare schemi di sopravvivenza, tuttavia l’uomo questo ancora non lo sa, vive nella stessa “scarsità ideologica” del passato. E’ per questo che l’attuale rivoluzione industriale sta mostrando un vuoto cognitivo che non è mai stato colmato.
La civiltà contemporanea, pur essendo in grado di produrre abbondanza e ricchezza per tutti, perpetua uno schema di scarsità. Questo schema non è solo economico, ma psichico. Alimenta competizione, dominio, paura della perdita. La maggior parte delle attivazioni relazionali avviene su questo piano, rendendo il conflitto la modalità primaria di interazione.
In questo scenario, l’individuo non si chiede più chi è, ma cosa deve difendere. E più difende, più si irrigidisce. La prigione non è imposta dall’esterno: è mantenuta dall’interno, attraverso comportamenti che sembrano necessari, ma che in realtà impediscono ogni reale trasformazione.
Il lavoro di coscienza, a questo livello, non consiste nel correggere i comportamenti, ma nel comprenderne la funzione. Ogni comportamento reattivo segnala un punto di frammentazione non ancora integrato. Finché questo punto resta invisibile, il comportamento continuerà a ripetersi. Quando viene visto, perde gradualmente la sua necessità. Solo allora l’uomo può iniziare a intravedere che esiste qualcosa oltre la sopravvivenza, oltre il ruolo, oltre la ripetizione. Ma questa intuizione, se non trova un centro più profondo, resta instabile. È per questo che la prigione interiore non si apre con uno sforzo morale, ma con un cambiamento radicale del punto di percezione.
La lettura moralistica ha reso questi concetti inefficaci, quando non addirittura colpevolizzanti. In realtà, ciò che viene chiamato “peccato” descrive una distorsione funzionale di una forza originariamente neutra e necessaria. Ogni essere umano dispone di energie fondamentali che servono alla vita, alla relazione, all’espressione e alla conoscenza. Quando queste energie vengono deviate, bloccate o assolutizzate a causa di vissuti irrisolti, si trasformano in automatismi che limitano la coscienza. È in questo senso che diventano sbarre: non perché siano “cattive”, ma perché imprigionano.
Le tradizioni esoteriche hanno spesso messo in relazione questi stati con specifici centri energetici o vortici di coscienza, ciò che in altre mappe viene chiamato chakra o chakra bloccato. Ma anche qui è importante evitare una lettura meccanica. Non si tratta di un centro “rotto”, bensì di una funzione che ha perso il proprio equilibrio.
Ad esempio, ciò che viene chiamato avidità non è altro che una fissazione dell’energia legata alla sicurezza e alla sopravvivenza. Quando l’essenza ha sperimentato una minaccia profonda, reale o percepita, quella funzione si irrigidisce e comincia a cercare compensazione nell’accumulo. Analogamente, l’ira è una contrazione dell’energia relazionale: nasce quando il confine è stato violato e la coscienza non ha avuto gli strumenti per difenderlo in modo lucido.
La lussuria, la gola, l’invidia, l’accidia e la superbia seguono la stessa logica. Non sono vizi da reprimere, ma segnali di un’energia che ha perso il proprio centro e cerca una via di sfogo. Ogni “peccato” indica un punto preciso in cui l’io si è frammentato e ha iniziato a reagire invece di scegliere.
In questo senso, la corrispondenza con i vortici energetici non va intesa come una mappa esoterica da studiare, ma come una chiave di lettura esperienziale. Ogni volta che un centro viene dominato dalla reattività, la coscienza si contrae attorno a quel punto e perde l’accesso a una visione più ampia. È così che la prigione si costruisce dall’interno, senza bisogno di mura esterne.
Il lavoro dell’Osservatore, e quindi del Cristo come forza di riunificazione, non consiste nel combattere questi stati, ma nel comprenderli. Quando una distorsione viene vista nella sua origine, l’energia che la alimentava si libera e torna disponibile. Non si tratta di diventare “virtuosi”, ma di tornare integri.
In questo senso, i sette peccati non sono l’elenco delle colpe dell’uomo, ma la mappa dei punti in cui l’uomo ha dimenticato se stesso. E riconoscerli come tali è già il primo atto di liberazione.
È importante aggiungere un ulteriore livello di lettura: quello dei comportamenti. Il vissuto irrisolto attiva stati emozionali che, mescolandosi tra loro, generano comportamenti biologicamente sensati in termini di sopravvivenza, ma profondamente frammentati per un essere che aspira alla pienezza, all’integrità morale e alla coerenza di intenti.
Le emozioni, prese singolarmente, non sono il problema. Il problema nasce quando uno stato emozionale si combina con una struttura identitaria rigida e non messa in discussione. In quel caso, l’emozione non viene attraversata, ma diventa motore di comportamento automatico.
Prendiamo ad esempio l’esperienza (vissuto) di essere stati trattati ingiustamente. Se questa percezione si mescola a un’identificazione con il proprio ruolo, con la propria immagine sociale o con un’idea fissa di sé, l’individuo non utilizza più l’emozione come segnale, ma come giustificazione. Qui emergono rancore, risentimento, e progressivamente comportamenti ossessivo-compulsivi e aggressivi. Questa è la vera natura della rabbia: non una forza esplosiva in sé, ma una reazione cronicizzata che nasce dall’impossibilità di rimettere in discussione la propria posizione.
In questo senso è necessario fare una distinzione chiara: l’uomo non è un essere sociale nel significato riduttivo che oggi viene attribuito a questa espressione. L’organizzazione sociale attuale è, in larga parte, una gestione del branco su scala estesa. L’uomo, però, non è un animale, anche se questa civiltà ha progressivamente abbassato i suoi bisogni, costringendolo a identificarsi con ruoli, funzioni e comportamenti che nulla hanno a che vedere con la sua reale natura.
Quando l’essere umano viene forzato entro ruoli che servono esclusivamente alla sopravvivenza del sistema, le emozioni diventano strumenti di adattamento e non più di comprensione. È così che le energie vitali si deformano e si trasformano in quelli che la tradizione ha chiamato peccati. Non come colpe, ma come esiti inevitabili di una vita vissuta fuori asse.
Visti da questa prospettiva, i vizi capitali non sono altro che comportamenti stabilizzati, cristallizzati e cronici, sostenuti da emozioni non elaborate e da un’identità non messe in discussione. Sono risposte coerenti a un mondo incoerente, ma diventano prigione nel momento in cui l’individuo smette di interrogarsi sulla loro origine.
Dire che la memoria si scioglie solo quando il corpo–psiche sperimenta una possibilità reale di scelta e riconosce che il tempo è diverso ci conduce direttamente alla natura della coscienza. Ciò che chiamiamo coscienza non è un contenuto, né uno stato particolare, ma l’atto stesso del rendersi conto. È questa presa d’atto che introduce una discontinuità nell’automatismo.
Il corpo–psiche, in sé, è una macchina. Funziona per associazione, ripetizione, previsione fino a realizzare sistemi aggregati più sofisticati di predizione rappresentati da un iperstimolazione della struttura della vista (retine, nuca e corteccia frontale) attivata da una minaccia percepita invisibile quando immaginata. È un sistema automatico orientato alla sopravvivenza, che risponde agli stimoli secondo schemi già iscritti. In assenza di coscienza, non c’è scelta, ma solo esecuzione. La risposta avviene prima che vi sia qualunque possibilità di verifica.
La coscienza entra in gioco nel momento in cui questo automatismo viene visto. Non lo interrompe con la forza, ma lo rende disponibile alla verifica. È solo allora che il corpo–psiche può fare un’esperienza nuova: riconoscere che, pur in presenza di stimoli simili a quelli originari, il tempo è cambiato. Questa differenza temporale non è concettuale, è vissuta. Ed è precisamente questa esperienza che permette alla memoria procedurale di sciogliersi.
In questo senso, la coscienza non “decide” al posto del corpo, ma rende possibile la scelta. Introduce uno spazio di mediazione che prima non esisteva. Senza questo spazio, la macchina umana resta prigioniera del passato. Con questo spazio, il presente diventa accessibile e il comportamento può aggiornarsi. In questo consiste la sintesi di quello che ho chiamato il binario di Bagdad così espresso: l’uomo quando ha fame non ragiona, quando ragiona non ascolta il Cuore, quando ascolta il cuore dimentica tutto.
Questa catena causale di eventi può essere interrotta solo introducendo una disciplina ferrea che passa dal curare i pensieri, questo perché i pensieri diventeranno parole. Cura le tue parole perché le parole diventeranno le tue azioni, cura le tue azioni perché le tue azioni diventeranno abitudini, cura le abitudini perché le abitudini diventeranno il tuo carattere, cura il tuo carattere perché diventerà il tuo destino. Quello che pensiamo, diventiamo, questa è l’unica vera legge che c’è: causalità, ne saremo per sempre assuefatti in quando termine umano ridondante, il resto è morale e non serve a cambiare, non serve alla rivoluzione della nostra Coscienza.
Sul Cuore come Organo di Percezione
“Accenna a un ‘Cuore non fisico’ capace di sovvertire leggi dell’apparenza. Come si connette questa facoltà al Tiferet cabalistico e alla dottrina del Sole Spirituale negli insegnamenti rosacrociani?”
Dopo aver descritto in modo rigoroso il funzionamento della macchina umana — corpo, psiche, emozione, comportamento, automatismo — diventa inevitabile porsi una domanda ulteriore: da dove può emergere una reale trasformazione, se tutto ciò che abbiamo osservato funziona per ripetizione e causalità?
La risposta non si trova in un livello superiore della mente, né in una maggiore capacità di controllo. Si trova in un cambio del punto di percezione. È qui che introduco ciò che chiamo Cuore, non come sede emotiva, ma come funzione percettiva. Il Cuore, così inteso, è l’occhio del ciclone. Non il centro statico, ma il punto di quiete in cui il movimento può essere visto senza essere immediatamente agito. È una funzione cognitiva, non sentimentale. Nelle tradizioni orientali è stato chiamato occhio unico, terzo occhio; nella Cabala corrisponde a Tiferet.
Tiferet non è un centro tra gli altri. È la congiunzione. È il punto in cui l’anima umana — con i suoi desideri, paure, slanci — e ciò che possiamo chiamare anima divina si incontrano. Non si fondono per annullamento, ma per allineamento. In questo spazio emerge una qualità nuova di percezione: l’esperienza di Sé come distinta dalla biologia e dalla psiche.
È qui che diventa necessario chiarire il tema della scelta.
La scelta, per come viene comunemente intesa, è un’illusione. È posta tra chi ha potere e chi non ne ha. Tuttavia il potere non è dominio sugli altri, né capacità di imporre una volontà. È Volontà-Cristo: una forza che nasce dal mondo intimo dell’essere e che non ha bisogno di giustificarsi.
Quando la coscienza illumina la psiche, la psiche sperimenta la possibilità della scelta. Ma questa possibilità è una concessione pedagogica. Serve a disinnescare l’automatismo, a creare spazio. In realtà, quando l’essere entra in contatto con la Volontà-Cristo, non sceglie: Sa. E ciò che segue non è deliberazione, ma inevitabilità.
L’azione che nasce da questo spazio non è morale, né eroica. È coerente. Non perché sia “giusta” secondo un criterio esterno, ma perché è allineata. In questo senso, la scelta è l’inganno necessario dell’ego affinché si faccia da parte. Quando l’ego crede di scegliere, l’essere può agire.
Questo chiarisce anche molte confusioni legate all’esperienza dell’innamoramento. Ciò che viene attribuito all’altro — intensità, apertura, senso di verità — è in realtà una qualità dell’essere che emerge quando il Cuore si apre. Se questa qualità non viene riconosciuta come propria, viene proiettata, e la relazione si traduce in scelta e diventa dipendenza. L’altro viene trasformato nell’oggetto necessario per rivivere uno stato che, in realtà, non dipende da lui.
Quando il Cuore è attivo, la relazione cambia natura. Non perché il mondo si trasformi magicamente, ma perché viene meno l’identificazione totale con la sua rappresentazione. Il velo di Maya non viene strappato: diventa coerente. Ma questa coerenza non è stabile finché i frammenti psichici non sono stati integrati. In loro assenza, l’esperienza del Cuore appare e scompare, lasciando dietro di sé nostalgia o appropriazione.
È per questo che il lavoro di integrazione resta indispensabile. La Volontà-Cristo non può incarnarsi in un sistema frammentato. Può solo affacciarsi. Quando invece il lavoro procede, quando i vissuti vengono riconosciuti e integrati, il Cuore diventa dimora. Non uno stato permanente, ma un riferimento stabile.
In questo spazio, l’essere umano non vive più come animale intellettuale. Non rinnega la biologia, ma non ne è prigioniero. Contiene in sé tutti i presupposti delle forme di vita su questo piano — nutrimento, riproduzione, territorio — ma non si esaurisce in essi. La direzione non viene scelta: viene sentita. E seguita.
Non è casuale che nella tradizione cabalistica e nei Tarocchi l’Arcano VI sia associato alla scelta e corrisponda alla sefirah Tiferet nell’Albero sefirotico. Questa iconografia non descrive una scelta morale tra opzioni equivalenti, ma una soglia percettiva. È il punto in cui l’essere umano crede di dover scegliere, mentre in realtà è chiamato a riconoscere una direzione.
La scelta, in questo senso, è l’ultima forma di mediazione concessa alla psiche prima che emerga la Volontà. Finché l’individuo resta identificato, vive la scelta come conflitto tra alternative. Quando invece Tiferet si attiva come funzione viva, la scelta si dissolve: non perché venga negata, ma perché diventa superflua. L’azione che segue non nasce da deliberazione, ma da allineamento. L’Arcano VI non rappresenta quindi la libertà di scegliere, ma il momento in cui l’illusione della scelta si consuma, lasciando spazio a ciò che deve essere fatto.
Il Cuore, in questo senso, mi ripeto, è l’occhio del ciclone: il punto in cui la percezione non viene trascinata dal movimento degli stati psichici, ma li attraversa senza identificarsi. Non è il centro emotivo dell’essere, ma il punto in cui la visione diventa possibile. L’occhio, simbolicamente, indica la capacità di vedere; quando questo punto è stabile, la visione non è più frammentata e diventa Coscienza.
Questo chiarisce perché il Cuore non è opposto alla mente né al corpo, ma li integra. È il luogo in cui l’essere può fare esperienza di sé come distinto dalla biologia e dalla psiche, senza negarle. Non produce stati, li rende visibili.
Sulla Matrix come Archetipo
“La prigione mentale da lei descritta ricorda il Nirmanakaya buddhista e il Pleroma gnostico. In che misura questa ‘matrice’ sarebbe un mandala dinamico, proiettato dall’interazione tra Logos individuale e Egregore collettivo?”
Quando utilizzo il termine Matrix non mi riferisco a una struttura artificiale né a un sistema ostile all’essere umano. Matrix va intesa nel suo significato originario: matrice, mater, madre. È lo spazio della manifestazione, il campo entro cui la materia e la coscienza possono esprimersi. Non è incompleta, né difettosa. È ciò che rende possibile l’esperienza.
Ciò che può essere incompleta è l’esperienza umana della Matrix, quando la coscienza è assente o intermittente. In questa condizione, l’essere umano non accede alla totalità del campo, ma solo a una porzione ridotta, filtrata dalla reattività, dagli automatismi e dalle identificazioni. Il problema non è quindi la struttura della manifestazione, ma la qualità della percezione che l’attraversa.
Quando l’individuo vive identificato con i propri automatismi, con i ruoli e con la reattività anacronistica, il mondo gli appare frammentato, ostile, competitivo, dominato dalla scarsità. Non perché la Matrix lo sia, ma perché la coscienza, non mediando l’esperienza, ne riduce drasticamente l’accesso. L’egregore collettivo e il Logos individuale non integrato concorrono così a produrre una visione del reale parziale, ma coerente con lo stato medio di coscienza.
In questo senso, la Matrix non è una prigione da cui fuggire, ma un campo da abitare. Quando l’Osservatore si attiva, quando il Cuore diventa funzione percettiva stabile e la Volontà-Cristo inizia a incarnarsi, la Matrix non viene negata né combattuta. Diventa leggibile. La coscienza non esce dal mondo: entra pienamente nel mondo.
Sul Sacrificio iniziatico
“Parla di ‘camminare sui cadaveri’ come atto di trascendenza. Come si concilia questa immagine violenta con la via della Compassione Attiva insegnata da certe scuole esoteriche, dove il distacco diviene paradoxicamente un abbraccio al mondo?”
Il processo sino qui descritto è un passaggio ed ha un costo, ed è ciò che le tradizioni hanno chiamato sacrificio iniziatico. Non si sacrifica qualcosa per ottenere altro, ma si lascia morire ciò che non può attraversare una percezione più ampia del reale: identità rigide, ruoli difensivi, appartenenze, immagini di sé, persino certezze spirituali. Tutto ciò che era necessario per sopravvivere in una coscienza frammentata diventa superfluo quando la coscienza si integra.
È in questo senso che utilizzo l’espressione camminare sui cadaveri. Non indica violenza né disprezzo. Indica la capacità di non restare legati a forme che hanno esaurito la loro funzione. Cadaveri sono le strutture interiori ed esteriori che non sono più vive, ma che vengono mantenute per paura del vuoto. Camminare significa procedere senza odio e senza nostalgia. Con “camminare sui cadaveri”, non intendo un atto di violenza verso l’altro, né una giustificazione dell’indifferenza. L’immagine è volutamente forte perché indica qualcosa che difficilmente può essere addolcito senza perdere verità: il sacrificio iniziatico è la rinuncia definitiva all’identificazione con ciò che deve morire.
I “cadaveri” non sono persone, anche se sarà nelle persone attorno all’iniziato, che mostreranno le identità che non hanno più vita reale: ruoli, immagini di sé, narrazioni personali, attaccamenti emotivi, perfino esperienze spirituali non integrate. Quell’uomo per questo definito iniziato, vede e sente compassione per il travaglio che ogni altro essere, le altre persone, saranno chiamati a compiere se vogliono la liberazione finale, vede le trappole attraverso le quali dovranno passare e quelle nelle quali restano invischiate. Ogni volta che l’uomo tenta di portare con sé queste strutture oltre la soglia, ne viene trattenuto. Il sacrificio non è quindi una scelta etica, ma una legge di passaggio e colui che lo ha attraversato o lo sta attraversando sente tutto il dolore dell’umanità che soffre nel rotolarsi nella sua inconsapevolezza; concetto difficile da capire senza cadere nel giudizio di pensarsi migliori. E’ di compassione Attiva che parlo.
In questo senso, il sacrificio iniziatico non è in contraddizione con la Compassione Attiva. Al contrario, ne è la condizione. Finché l’individuo è identificato con i propri frammenti, la compassione resta mescolata al bisogno, al controllo, alla proiezione, alla presunzione ed al sentirsi superiori, migliori e dalla parte del giusto. E questo è il peggiore degli aspetti dell’ipocrisia iniziatica, si “aiuta” per colmare una mancanza, per sentirsi giusti, per mantenere un’immagine di sé. Questo non libera né sé stessi né l’altro.
La compassione autentica nasce solo quando l’uomo ha smesso di salvare gli altri, quando ha smesso di salvare se stesso attraverso gli altri. Quando l’identificazione crolla, ciò che rimane non è distacco freddo, ma una presenza capace di stare nel mondo senza essere catturata dalle sue dinamiche. È un abbraccio che non trattiene, un agire che non pretende.
Il sacrificio iniziatico è quindi l’atto con cui l’individuo accetta di non portare oltre ciò che non può attraversare la soglia. Non per disprezzo, ma per lucidità. In questo senso, camminare sui cadaveri significa non voltarsi indietro a cercare ciò che è già morto, anche se un tempo lo si è chiamato “me”.
È qui che il paradosso si compie: solo chi ha rinunciato a tutto può tornare nel mondo senza appartenervi. Solo chi ha sacrificato l’identificazione può agire senza violenza. E solo chi ha attraversato questa morte interiore può incarnare una compassione che non salva, ma libera.
Qui emerge quello che ho definito dolore lucido. È il dolore che nasce quando la coscienza vede senza potersi più sottrarre. Non è emotivo né drammatico. È il dolore di chi riconosce la perdita di senso collettiva e non può più fingere di non vederla. Quando questo dolore attraversa l’essere, non lo spezza: lo rafforza. Una forza innata percorre il corpo e la presenza generale, rendendo possibile restare nel mondo senza irrigidirsi ma compartendo col prossimo il valore acquisito senza esaltazioni o manifestazioni esteriore al di fuori del suo essere reale.
In questo spazio, la compassione smette di essere un sentimento e diventa una postura dell’essere. Non è salvataggio, non è sacrificio di sé per l’altro, non è superiorità morale. È la capacità di restare presenti nella Matrix senza alimentarla con la propria reattività. È un abbraccio che non trattiene.
Il sacrificio iniziatico non conduce altrove. Riporta qui. Ma in un qui finalmente abitato. L’essere umano non trascende la Matrix fuggendo dal mondo, ma cessando di ridurre la propria esperienza del mondo. Non diventa migliore, né più elevato. Diventa responsabile, perché vede.
E questa responsabilità non è un dovere morale. È una conseguenza naturale della coscienza. Quando si vede, non si può più tornare indietro. Si può solo procedere, con sobrietà, nel campo della manifestazione così com’è, senza più chiedergli di essere altro, e senza più ridursi a meno di ciò che si è.
Rocco Bruno
RVSCB